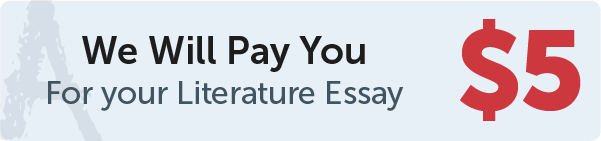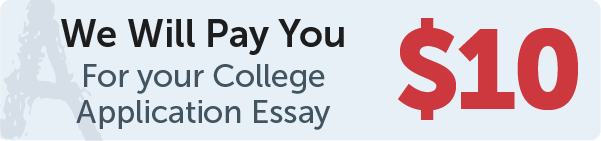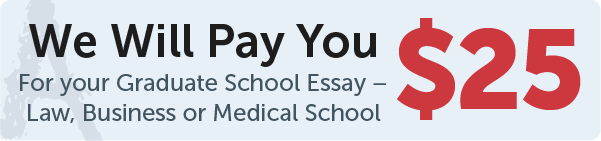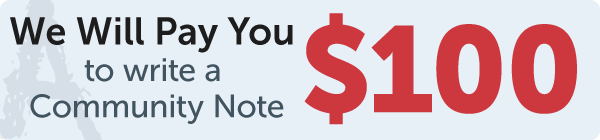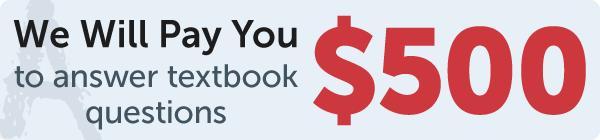Foe di J.M. Coetzee ripropone una storia familiare al pubblico, sfidando però quella stessa familiarità. Anche chi non ha mai letto il romanzo Robinson Crusoe ha una conoscenza relativamente buona di quest’iconico ritratto della sopravvivenza a seguito di un naufragio e anche della dipendenza di Crusoe da Venerdì, il suo compagno nero. E se ci fosse stato un altro naufrago che ha giocato un ruolo di vitale importanza nel racconto di quell’isola, la cui storia è stata omessa?
Coetzee introduce questo tema affascinante e pungente facendo raccontare la sua versione da un personaggio completamente nuovo su quell’isola deserta, Susan Barton. E ancora più pungente e affascinante è l’aggiunta del personaggio del titolo a un racconto che, nella sua familiarità, viene trasformato in una meta-narrazione sconosciuta e postmoderna. Alla fine, questa narrativa costringe coloro che hanno già letto Robinson Crusoe a tornare indietro e metterlo a confronto con la versione di Coetzee.
Daniel Defoe (Foe) avrebbe comprato la storia di Crusoe, Venerdì e Susan Barton dalla stessa Barton, sull’orlo della disperazione. Defoe la tradisce modificando la storia per renderla propria. Venerdì non può dare una sua versione dei fatti perché gli è stata tagliata la lingua. Lei decide di scrivere la vicenda, ma fatica a comunicare con Venerdì, in quanto muto.
Per comprendere il contesto di questa versione è importante la permanenza di Coetzee, uomo bianco, in Africa. In quanto tale, il tema di una persona nera incapace di raccontare la propria storia e la battaglia economica e artistica nella fretta di raccontare una storia, raggiungono un nuovo livello di importanza, rendendo Foe molto più che semplicemente l’ennesima reinvenzione postmoderna di una storia raccontata da una prospettiva leggermente diversa.